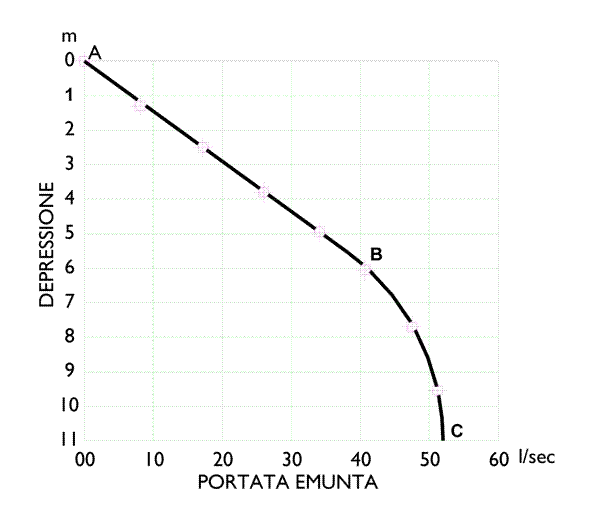curve caratteristiche pompe
1. PREMESSA
Nella progettazione delle reti acquedottistiche si riscontra sovente la necessità di determinare a priori le caratteristiche delle pompe di sollevamento da utilizzare. Il problema diventa arduo quando si è in presenza di sollevamento diretto in rete che, se effettuato con pompe a velocità di rotazione variabile, a fronte di una ottima versatilità, apporta ulteriori incognite. I dati di portata e prevalenza nel punto di inserimento in rete della pompa che soddisfano le varie condizioni di calcolo delle reti idriche complesse sono infatti noti solo alla fine delle iterazioni di calcolo, quando la rete è equilibrata in tutte le sue componenti ivi compresa la pompa stessa. Possono aversi risultati imprevedibili come ad esempio l’utilizzazione della pompa con prevalenze esageratamente elevate e quindi portate quasi nulle oppure prevalenze bassissime e portate cospicue: in ambedue i casi la macchina lavorerebbe con rendimenti inaccettabili.
La soluzione non può che derivare dall’esame di svariate versioni progettuali redatte introducendo nei calcoli le curve caratteristiche di più pompe, esaminandone i dati di funzionamento nelle diverse situazioni e, nel caso della velocità variabile, supponendo di variare anche la velocità di rotazione dei motori dell’intera serie di pompe. Dopo aver definito sia pur a grandi linee quali sono quelle da adottare, si potrà passare alla verifica finale adottando le curve reali relative a pompe effettivamente reperibili in commercio ed aventi caratteristiche similari di quelle calcolate.
Al raggiungimento di tale importante risultato possono contribuire gli accorgimenti suggeriti nel presente articolo.
2. POMPE A VELOCITÀ DI ROTAZIONE FISSA
Si usa definire in modo approssimato le caratteristiche di una pompa con due soli elementi: portata e prevalenza. E’ ben noto come dovrebbe invece essere la sua curva caratteristica cioè la funzione matematica che lega la portata alla prevalenza di sollevamento a definirla, potendo la stessa pompa lavorare con portata elevata se è richiesta una modesta prevalenza come pure solo basse portate quando è rilevante il dislivello da vincere.
La curva viene normalmente fornita dal costruttore della macchina ed è la sola che può indicare le sue reali modalità di uso, anche perché consente la verifica dei rendimenti elettromeccanici alle varie condizioni di funzionamento.
Come detto nella premessa è talvolta molto utile poter fissare delle caratteristiche indicative di tali curve che, anche se approssimate, tornano utili per risolvere almeno nelle sue linee generali i problemi idraulici posti dalla rete in esame, tenuto conto oltre alle pompe anche di molteplici fattori anch’essi incerti ed approssimati come sono la costituzione delle maglie, il diametro delle condotte, la presenza o meno di apparecchiature di regolazione, le valvole di riduzione della pressione, i serbatoi presenti in rete ecc. ecc. Si tratta di fattori concomitanti alla cui definizione non si può giungere che per approssimazioni successive.
Allo scopo si ritiene utile porre qui in evidenza alcuni elementi empirici ma che hanno una certa attinenza con quelli effettivi delle pompe di sollevamento in normale uso. Essi sono stati dedotti da un programma applicativo molto usato per la verifica del funzionamento idraulico in moto permanente delle reti di distribuzione degli acquedotti nel quale tali regole sono comunemente adottate.
Si tratta del programma applicativo “EPANET” sviluppato da Water Supply and Water Resources Division (formerly the Drinking Water Research Division) of the U.S. Environmental Protection Agency’s National Risk Management Research Laboratory e diffuse in tutto il mondo.
Le regole consigliate sono le seguenti.
Si inizierà con la definizione di un suo solo punto e cioè della portata e della prevalenza che si pensa sia la più opportuna per il caso in esame. Si tratta del punto Qm/Hm mediano della curva caratteristica da imporre. E’ ben noto come per definire una qualsiasi curva i punti debbano invece essere, come minimo, in numero di tre. Si determineranno gli altri due adottando le regole empiriche riportate nella seguente tabella:
| Punto | Portata | Prevalenza |
| Q0 (portata zero) | 0 | 1.33 * Hm |
| Qm (portata media data) | Qm | Hm |
| Qmax (portata massima) | 2 * Qm | 0 |
Ad esempio volendo determinare la curva caratteristica di una pompa avente una portata media di 5 l/sec ad una prevalenza di 30 m si otterranno i seguenti dati:
| Punto | Portata | Prevalenza |
| Q0 (portata zero) | 0 | 1.33 * 30 = 40 m |
| Qm (portata media data) | 5 | 30 |
| Qmax (portata massima) | 2 * 5 = 10 l/sec | 0 |
La rappresentazione grafica della curva è quella indicata con A, B, e C nel grafico allegato di fig.1.
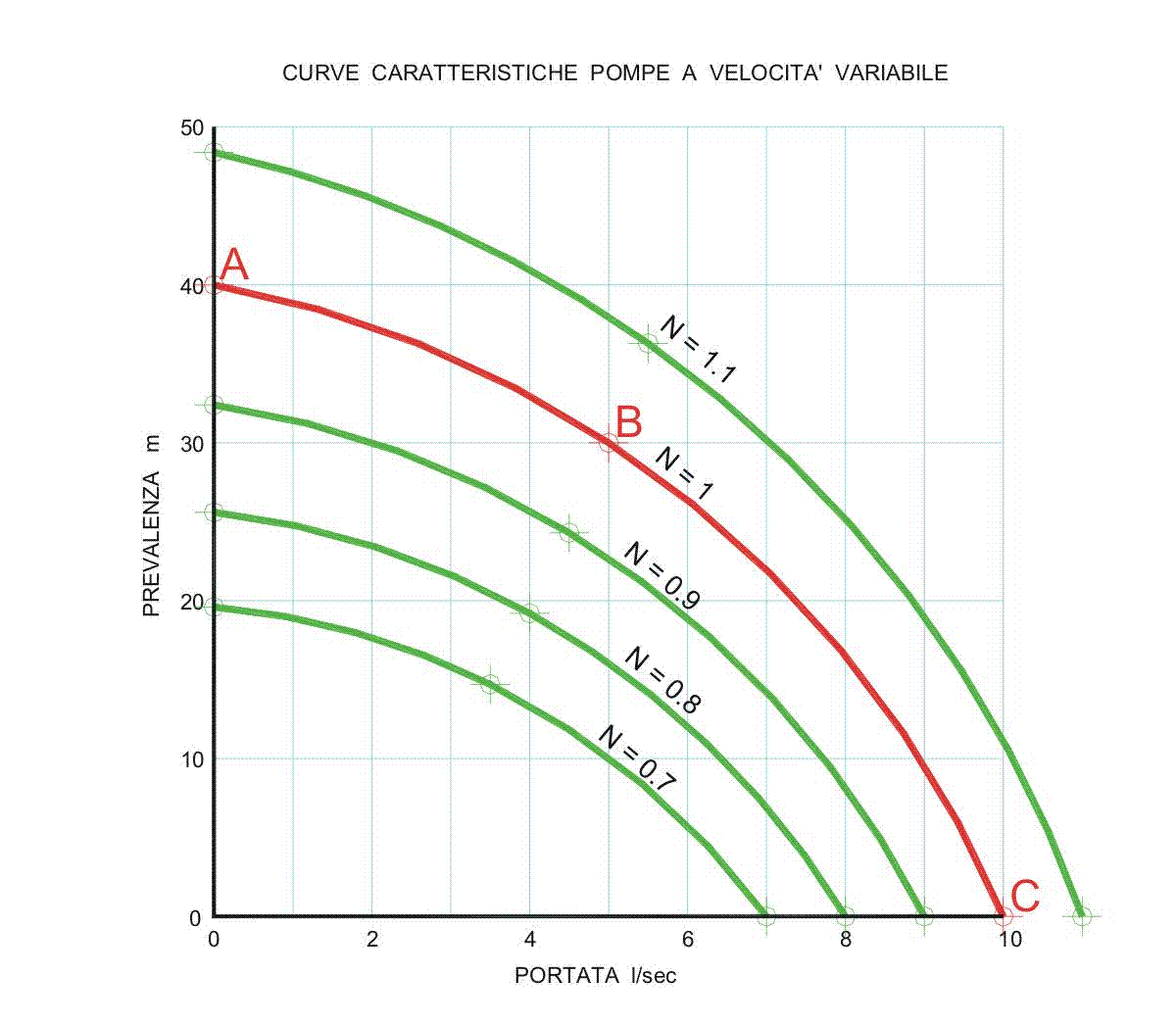
3. POMPE A VELOCITA’ DI ROTAZIONE VARIABILE
L’adozione di pompe a velocità variabile, facilitata dalla moderna elettrotecnica ed elettronica che si basa sugli inverter, consente di ottenere grandi benefici per le elevate possibilità di regolazione delle sue portata e prevalenza. Analogamente a quanto detto per le pompe a velocità fissa, anche ed ancor di più per quelle variabili, è essenziale poter introdurre preventivamente nei calcoli le relative caratteristiche sia pure con le inevitabili approssimazioni.
Le regole che legano tra di loro le curve portata/pressione di una stessa pompa al variare della sua velocità di rotazione sono le seguenti, essendo Q la portata, N il numero di giri nell’unità di tempo ed H la prevalenza di pompaggio:
| Velocità di rotazione | Portata | Prevalenza |
| N1 | Q1 | H1 |
| N2 | Q2=Q1*N2/N1 | H2= H1/(N1/N2)*(N1/N2) |
Facendo riferimento all’esempio prima riportato si avrà quindi:
| Velocità rotazione | Portata | Prevalenza |
| N1 = 1 (dato base) | Q0=0 | Qm= 5.0l/sec | Qmax= 10 l/sec | H0= 40.0m | Hm= 30.0 m | Hmax = 0 |
| N = 1.1 | Q0=0 | Qm= 5.5l/sec | Qmax= 11 l/sec | H0= 48.4m | Hm= 36.3 m | Hmax = 0 |
| N= 0.9 | Q0=0 | Qm= 4.5l/sec | Qmax= 9 l/sec | H0= 32.4m | Hm= 24.3 m | Hmax = 0 |
| N=0.8 | Q0=0 | Qm= 4.0/sec | Qmax= 8 l/sec | H0= 25.6m | Hm= 19.2 m | Hmax = 0 |
| N=0.7 | Q0=0 | Qm= 3.5/sec | Qmax= 7 l/sec | H0= 19.6m | Hm= 14.7 m | Hmax = 0 |
La rappresentazione grafica delle curve caratteristiche complete è quella della figura n-1 allegata.
4. BREVI CENNI SUI CALCOLI DI VERIFICA DELLE RETI MAGLIATE
Come noto, non è possibile determinare direttamente col calcolo le caratteristiche dei vari componenti delle reti idriche complesse ma bisogna invece procedere per tentativi tramite una successione di verifiche di schemi predefiniti.
Di contro sono notevoli le possibilità offerte dai moderni programmi di calcolo delle reti magliate in quanto, oltre a considerare schemi idrici anche molto complessi per costituzione delle maglie e per la presenza di apparecchiature idriche anche in grande numero e di qualsiasi tipo (valvole, pompe sia a giri fissi che variabili, serbatoi inseriti direttamente in rete, pozzetti di interruzione ecc. ecc.), consentono di simulare lunghe sequenze di reti in moto permanente tenendo conto delle variazioni che intervengono nel periodo temporale da esaminare e definendo tutti gli elementi di funzionamento ivi compresa l’evoluzione dei serbatoi direttamente inseriti in rete. Si tratta di risultati notevolissimi con i quali è possibile prevedere a tavolino le soluzioni ottimali di progetto. Ovviamente la bontà dei risultati dipende dalla qualità dei dati di partenza che bisogna introdurre in quanto, come detto, si debbono sempre fare delle verifiche di una rete fissata a priori. In questo senso, per quanto riguarda specificamente gli impianti di sollevamento, diventa importante la possibilità di potere esaminare il comportamento di diversi gruppi pompa ripetendo più volte la verifica a seconda del tipo e del numero di pompe che si intende provare. Da rilevare, a tale proposito, come una stessa seduta di calcoli, possa comprendere non solo una rete che viene esaminata nella evoluzione di periodi anche prolungati, ma anche più reti diversificate delle quali il computer determina in sequenza tutte le preimpostate varianti rendendo rapida la disamina dei risultati e la scelta della soluzione ottimale. Si potranno quindi vagliare soluzioni che si diversificano nella scelta dei tracciati o dei diametri delle condotte, nella presenza o meno di serbatoi di compensazione, nella diversa evoluzione delle richieste di rete e, in virtù delle indicazioni fornite nel presente articolo, nella portata e prevalenza delle pompe e, a parità di pompa, nel cambiare di ora in ora la sua velocità di rotazione.
5. CONCLUSIONI
Si sono indicate delle regole empiriche per poter tracciare le curve caratteristiche portata/prevalenza di pompe siano esse del tipo tradizionale a giri fissi come pure a velocità variabile. Si tratta di determinarne l’andamento di massima necessario ma sufficiente per le verifiche generali delle reti di distribuzione con il calcolo di insiemi acquedottistici anche complessi, oggi reso possibile dall’uso dei computer.
La procedura qui consigliata consiste nell’effettuare una nutrita serie di verifiche usando, per gli impianti di sollevamento, delle serie di curve caratteristiche delle pompe in modo da determinare la macchina che, nella prima fase di calcoli, risulta ottimale. Si potrà allora effettuare la verifica definitiva ricercando tra quelle disponibili in commercio la pompa di caratteristiche simili a quella suddetta ed utilizzando la curva caratteristica reale fornita assieme dal costruttore della pompa stessa e controllandone, in detta fase, anche i rendimenti elettromeccanici.
Nell’articolo la indicazione delle formule empiriche da usare è completata da un esempio di determinazione pratica delle curve caratteristiche di una pompa considerata funzionante alla tradizionale velocità fissa e, successivamente, determinando una serie di curve anche per la eventuale utilizzazione a diverse velocità di rotazione.
Per maggiori dettagli sull’uso delle pompe vedi “L’utilizzazione delle elettropompe a velocità variabile negli acquedotti” in questo stesso sito